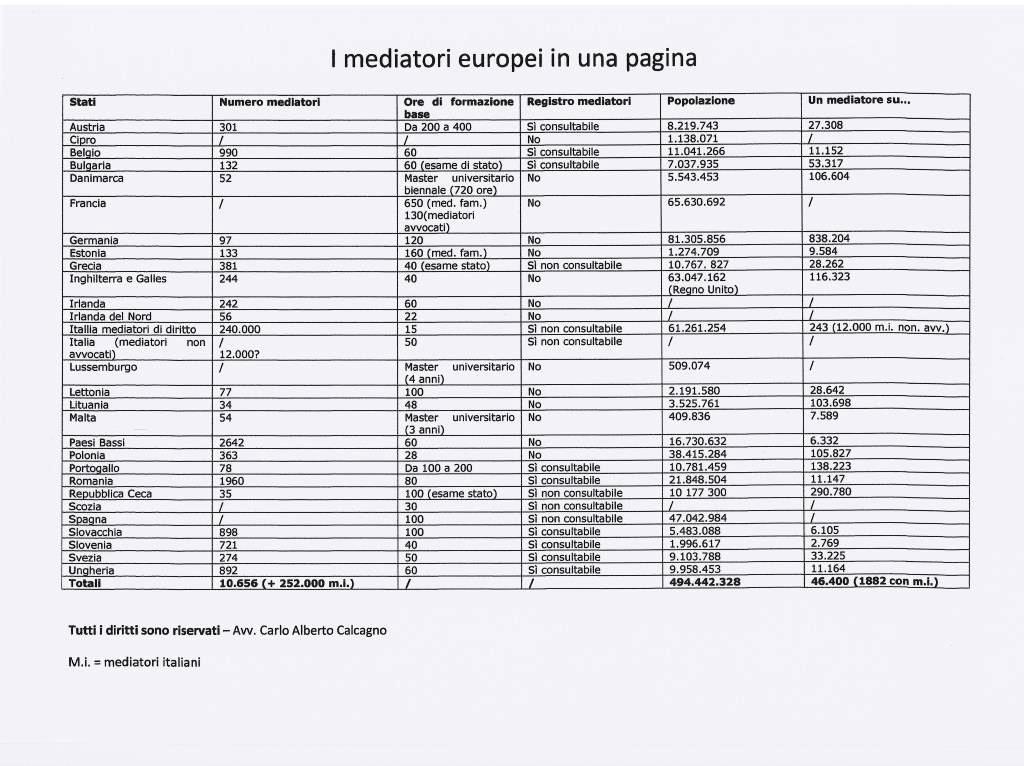Argentina
Quando si programma un percorso di risoluzione alternativa.
Dato che in questi giorni si parla molto di studi e statistiche io vorrei rifarmi per esempio a quelle di un tribunale argentino, quello di Formosa una cittadina di 200.000 abitanti che si affaccia sul fiume Paraguay.
Mi ha colpito il fatto che nel 2012 i casi di mediazione numericamente più rilevanti sono stati quelli di presentazione volontaria. E che questo sia avvenuto anche nel 2011 e nel 2010. (http://www.jusformosa.gov.ar/mediacion/ESTADISTICAS.pdf).
Ora in Argentina sussiste la piena condizione di procedibilità: essa è stata vissuta dai cittadini in via provvisoria e sperimentale dal 1996 sino al 2011 (era in vigore Ley 24,573 in http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29037/texact.htm) e poi si è deciso di disciplinarla stabilmente con la legge 26589 del 15 aprile 2010 ( http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/166999/norma.htm).
Alla fine di questo percorso il cittadino di Formosa vive evidentemente la mediazione come regola e non come eccezione.
A fronte di ciò si potrebbe concludere che da noi che abbiamo un sistema simile a quello argentino (o almeno lo avevamo prima dell’intervento della Consulta), visto che siamo partiti nel 2010 e che abbiamo una mentalità vicina a quella argentina (siamo anche noi neolatini), vedremo i primi frutti nel 2025.
Ma potrebbe essere una conclusione affrettata.
In Argentina la cultura della mediazione ha preso campo a distanza di 15 anni a seguito di un certo viatico: durante la dittatura alcuni sono andati a studiare l’ADR negli Stati Uniti, poi sono tornati quando il paese è stato liberato, hanno dibattuto su chi potesse fare il mediatore e individuato il mediatore gli si è chiesto di studiare la mediazione per alcuni anni, contemporaneamente si è domandato ai giudici che cosa ne pensassero dell’istituto e se fossero disponibili a partecipare a programmi sperimentali pilota. A questo punto dopo un dibattito che ha permeato tutta la società si è partiti ed oggi si è arrivati dove si è arrivati.
Il nostro modo di affrontare la mediazione è stato molto diverso: noi siamo partiti da una legge stabile ossia dal tetto per poi accorgerci che era meglio che l’istituto fosse sperimentale; chi abbiamo consultato al proposito io non l’ho ancora capito e si è iniziato a studiare mediazione dopo la pubblicazione della legge: ciò è accaduto non solo per i mediatori, ma più un generale (salve le eccezioni naturalmente) anche per i formatori; in questo quadro si sono addirittura accettati dei responsabili scientifici che non erano né mediatori, né formatori. Invece di concertare i modelli con gli operatori del settore che ormai si sono fatti un po’ di esperienza si è preferito inventare i modelli.
E dunque chissà se nel 2025 chi ci sarà parlerà ancora di mediazione…
Compenso del mediatore argentino
Il mediatore argentino (avvocato con almeno 5 anni di esperienza) che lavora in Camera di commercio (CEMARC) ha diritto ad un compenso proporzionale al valore dell’accordo raggiunto. Nel caso in cui le parti non si accordino per un maggiore valore si applicano le seguenti tariffe (onorario fisso + una percentuale sull’eccedenza rispetto allo scaglione di riferimento):
Valore dell’accordo Onorario fisso Onorario percentuale sulla eccedenza
0 30.000 600 0,00% 0
30.001 100.000 600 2,00% 30.000
100.001 200.000 2.000 1,80% 100.000
200.001 300.000 3.800 1,60% 200.000
300.001 400.000 5.400 1,40% 300.000
400.001 500.000 6.800 1,20% 400.000
500.001 600.000 8.000 0,80% 500.000
600.001 700.000 8.800 0,60% 600.000
700.001 800.000 9.400 0,40% 700.000
800.001 900.000 9.800 0,20% 800.000
900.001 e seguente 10.000 0,00% 900.000
Il sistema appare dunque più equilibrato del nostro perché la tariffa è solo sussidiaria alla volontà delle parti.
http://www.cac.com.ar/documentos/34_REGLAMENTO%20DE%20MEDIACIoN%20%2012dic07%2001set08.pdf
Austria
E’ notizia del 22 gennaio 2014 che in Austria il tasso di successo della mediazione è superiore al 50%.
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/recht_steuern/1552285 on_Erfolgsrate-liegt-uber-50-Prozent
Da noi invece si pensa alle camere arbitrali…
Forse abbiamo paura di poter raggiungere la stessa percentuale?
Bangladesh
I mediatori sono professionisti di grande rilevanza: la stampa straniera dà notizia di quando essi vengono accreditati; così è accaduto da ultimo per il Bangladesh ove ad esempio nel mese di settembre sono stati creati 22 nuovi mediatori (http://www.mediate.com/nlpreview.cfm). Noi invece come avvocati non abbiamo nemmeno la gioia della conquista; farebbe invece notizia un collega che non volesse essere considerato mediatore di diritto…
Per un giudice del Bangladesh
“A lawyer is the trusted legal expert of his client. If a lawyer is not fully aware of the benefits of mediation and he does not encourage his client for mediation then it will be difficult to make the exercise a success,” said Mr. Justice Md. Muzammel Hossain, Hon’ble
Chief Justice of Bangladesh while attending the programme as a chief guest.
http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/presscenter/articles/2013/10/17/taking-mediation-to-the-masses-/
Scelta illuminata del Bangladesh
Il Bangladesh è attualmente il quinto paese più lento del mondo per far rispettare un contratto (1442 giorni).
Già nel 2003 si è data la possibilità alle parti di risolvere le controversie fuori dal processo, ma l’utilizzo è stato scarso.
Così Il codice di procedura civile è stato modificato alla fine di settembre 2012 e si è resa la mediazione obbligatoria per tutti i casi, tra cui quelli che coinvolgono in controversie civili e commerciali.
La modifica non è entrata in vigore poiché si attende che siano formati i mediatori, i giudici e gli avvocati.
L’avvocato Saqeb Mahbub membro della Corte Suprema del Bangladesh definisce il provvedimento ultimo in questo modo: “La legislazione rendendo la mediazione obbligatoria in tutti i casi civili è certamente un passo nella giusta direzione. Il potenziale della mediazione obbligatoria nella sua promozione del commercio e degli investimenti esteri è immenso. Deve ora essere seguita dalla creazione delle infrastrutture e dalla costruzione della capacità di un sistema giustizia che faciliti la mediazione”.
(http://www.thefinancialexpress-bd.com/old/index.php?ref=MjBfMTBfMDNfMTNfMV85Ml8xODU2MTI%3D)
Inoltre con un progetto pilota in Bangladesh si consente ai contribuenti di risolvere in via amichevole stragiudiziale e con l’aiuto di un facilitatore (appartenente ad un panel selezionato dalla CC.I.AA.: 22 mediatori sono stati ad oggi formati), le controversie attinenti a:
a) imposta sul reddito,
b) imposta sul valore aggiunto (IVA)
c) e le controversie doganali.
Tempo stimato per la risoluzione delle controversie: 30-60 giorni.
La scelta di politica fiscale si basa su un progetto sudafricano del 2003 ed è sostenuta finanziariamente dalla banche.
Brasile
Novità rilevanti per la mediazione in Brasile
La Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, una commissione del senato brasiliano, ha approvato un nuovo progetto sulla mediazione (Projeto que disciplina a mediação judicial e extrajudicial) in data 11 dicembre 2013.
Dopo un voto della plenaria del Senato, dovrebbe passare alla Camera.
La norma che disciplina uno strumento volontario, non disciplina la mediazione nell’ambito familiare.
Interessante è che questo progetto di legge prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione debba incoraggiare gli istituti di istruzione superiore ad includere la disciplina della mediazione come materia di studio e che il Consiglio federale brasiliano dell’Ordine degli Avvocati dovrebbe includere le questioni relative alla mediazione nelle prove d’esame per gli avvocati (Cfr. http://senado.jusbrasil.com.br/noticias/112215575/projeto-que-disciplina-a-mediacao-judicial-e-extrajudicial-e-aprovado-pela-ccj).
Particolare la formazione per i mediatori del panel giudiziario che devono frequentare apposita scuola biennale.
Le parti possono anche essere assistite da avvocati. Se solo una è assistita l’altra può chiedere la nomina di un difensore d’ufficio.
Mentre la mediazione extragiudiziale non ha alcun termine (misura questa assai opportuna!) quella giudiziale ha un termine di 60 giorni decorrenti dalla prima seduta.
Il progetto approvato prevede inoltre di mediazione per i conflitti che coinvolgono agenzie ed enti governativi.
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp
Buthan
Il Buthan è uno strano paese paese in cui il procuratore generale ha fatto scrivere sul suo sito istituzionale “Meglio che dieci innocenti sfuggano piuttosto che un innocente soffra” (William Blackstone). Ma ancora più bizzarro è il pensiero del Re del Buthan che nel 2013 a commento di un corso di mediazione per formare giudici ed avvocati ha esclamato:”most important of this training is to provide service to our people and enhance access to justice by becoming good teachers and trainers”.
Curioso paese il Buthan ove si cerca la verità, la pace, la conoscenza e la felicità.
http://oag.gov.bt/
Canada
In Canada dal 2014 i professionisti delle controversie familiari devono possedere nuovi requisiti
Nel 2012 è stato approvato il nuovo Family Law Act che entrato in vigore 18 marzo 2013 (il precedente era del 2005).
La norma (V. ART. 245http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/LOC/freeside/–%20F%20–/Family%20Law%20Act%20SBC%202011%20c.%2025/00_Act/11025_12.xml#section245) prevede nuovi requisiti di formazione per i professionisti della risoluzione delle controversie familiari a partire dal 1 gennaio 2014.
Si richiede in particolare che siano soddisfatti gli standard specifici in merito alla violenza in famiglia, ricomprendendo la formazione per riconoscere la violenza in famiglia, ed un livello minimo di formazione teorico e pratica annuale in materia familiare.
Gli avvocati che agiscono come i professionisti di risoluzione delle controversie devono rispettare gli standard di formazione e di pratica equivalenti, secondo quanto previsto dal Ministero della Giustizia.
Mediazione obbligatoria in Canada per servizi bancari e finanziari
Dal 1° maggio 2014 in Canada il Mediatore per i servizi bancari e gli investimenti (OBSI) dovrà essere il mediatore utilizzato obbligatoriamente in tutte le giurisdizioni in Canada (ad eccezione del Quebec).
Le aziende bancarie e di investimento iscritte ad OBSI una volta che riceveranno il reclamo dovranno far presente agli utenti che utilizzano il servizio indipendente di OBSI.
Altri provider non possono essere utilizzati se non in caso eccezionale.
Gli utenti avranno tempo 6 anni per adire OBSI, trascorsi 90 giorni dalla risposta negativa o senza che vi sia una risposta.
Le aziende possono rispondere anche oltre il termine di 90 giorni, ma in tal caso l’utente può modificare in conseguenza entro 180 giorni la domanda di mediazione ad OBSI.
Il servizio di risoluzione delle controversie è a carico delle aziende bancarie e di investimento.
Gli utenti che vogliano utilizzare un altro provider lo fanno a proprie spese.
Si può adire OBSI solo per somme inferiori ai 350.000 dollari.
http://www.mondaq.com/canada/x/283292/Securities/OBSI+Mandatory+ADR+for+All+Canadian+Securities+Registrants+Coming+May+1+2014&email_access=on
Cina
Trasparenza cinese
Il 28 novembre 2013 in Cina la Corte suprema del popolo ha deciso di mettere online tutte le decisioni giudiziarie e i lodi arbitrali (non le mediazioni) in modo che il popolo possa esprimere la sua opinione al proposito dell’operato dei giudici.
http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/11/id/1152212.shtm
Germania
Studio sulla mediazione
Uno studio tedesco molto recente ha dato i seguenti esiti.
Il 48% dei cittadini considera la mediazione una procedura ottima
Il 56% dei cittadini ritiene la mediazione stragiudiziale tedesca un buon modello.
Il 68% dei giudici tedeschi approva il modello del guterichter (giudice che media e non decide)
I Giudici ed i pubblici ministeri considerano utile la mediazione nelle questioni familiari e di prossimità.
L’85% dei cittadini tedeschi ritiene che la conciliazione preventiva obbligatoria presente nei Lander è cosa utile.
Metà dei giudici e dei pubblici ministeri ritengono gli ADR utili e l’altra metà li utilizza.
In materia di divorzio la mediazione è approvata dal 60%, mentre i contrari sono il 36%.
la maggioranza dei tedeschi vuole evitare il processo per il rischio finanziario (si vede che noi siamo più ricchi…)
Sotto i 1950 € al processo non ci pensa nessuno.
Come è possibile che dall’altra parte del confine ci siamo noi?
http://www.centrale-fuer-mediation.de/35000.htm
Mediazione insolita
Mercoledì scorso in Germania si è celebrata una mediazione che nei prossimi giorni si concluderà con una proposta non vincolante.
Il caso è molto particolare: alcuni eredi di mercanti antiquari ebrei sostengono che i loro parenti hanno venduto obbligatoriamente e sotto costo per la pressione della persecuzione razziale alcuni tesori allo stato nazista e la Fondazione prussiana dei Beni Culturali, che sovrintende il museo di Berlino che ora detiene il tesoro, sostiene al contrario che i venditori hanno ricevuto “un prezzo equo e adeguato”. Chissà come andrà a finire. Di certo la vicenda ha un grande valore morale a prescindere da quello economico.
http://www.thelocal.de/20140116/panel-fails-to-rule-over-stolen-church-treasures#disqus_thread
Mediazione e assicurazione in Germania
Mentre in Germania le compagnie di assicurazioni considerano la mediazione come un utile strumento (e ciò secondo uno studio del febbraio-marzo 2013; cfr. http://www.mediation.de/rechtsschutz), in Italia si è invece deciso di stralciare la condizione di procedibilità sul punto.
Ci sono ben 31 assicurazioni in Germania (cfr. http://www.mediator-finden.de/mediation/mediation-und-rechtsschutz) che coprono anche i costi da mediazione, perché i costi delle spese legali sono enormemente lievitati.
Vi è addirittura un invito del sito http://www.mediation.de/rechtsschutz a controllare le spese legali: sul sito http://www.spiegel.de/wirtschaft/prozesskostenrechner-was-der-gang-vor-den-kadi-kostet-a-237919.html si può agevolmente verificare quanto può costare un processo; ho provato personalmente a mettere un importo di € 20.000 a titolo di esempio ed è venuto fuori un valore di 6.372,29 €.
http://www.mediator-finden.de/mediation/mediation-und-rechtsschut
Condizione di procedibilità
Nel 1418 il Consiglio della lega Anseatica varò questo bellissimo regolamento:
1) Ogni confederato è tenuto a scambievole assistenza e difesa.
2) Ove uno dei membri venga assalito, la Lega darà opera perché tutto si termini in via di conciliazione.
3) Nel caso che l’assalitore non intendesse desistere dalle ostilità tutte le città confederate dovranno entro 14 giorni porger sussidio alla sorella assalita d’uomini e di denaro, secondo è stabilito dalla matricola dello Stato (la matricola era la quota imposta a ciascuna confederata).
4) Nessuna città potrà, senza l’assenso delle quattro città anseatiche più vicine, dichiarar guerra qualsivoglia principe o stato.
5) Parimenti è vietato segnar paci parziali senza l’intervento del congresso.
6) Se fra due città della Lega insorgessero querele, toccherà aggiustarle a quattro città sorelle e il loro giudizio sarà inappellabile.
Giappone
Notizia del 23 dicembre 2013 è che in Giappone la metà delle controversie mediche sono risolte in mediazione.
http://www.car-molds.com/medical-dispute-mediation-settlement-japan/
Grecia
Il 23 dicembre 2013 sono stati presentati alla Camera delle piccole e medie imprese di Atene (BEA) 75 mediatori avvocati che hanno superato il prescritto esame di stato e che verranno iscritti nell’elenco del Ministero della Giustizia.
Auguro ai colleghi ellenici di portare alto il nome della mediazione nel mondo.
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=259512&catid=3
Inghilterra
Il Ministro della Giustizia inglese punta sulla mediazione familiare
Nel settembre del 2013 il ministro della Giustizia inglese, Lord McNally, ha affermato: “La mediazione può essere più veloce, più economica e produce risultati migliori delle stressanti battaglie giudiziarie in campo familiare – e siamo impegnati ad aiutare più coppie che si separano affinché utilizzino gli eccellenti servizi disponibili. Milioni di sterline di patrocinio sono ancora disponibili per coprire i costi della mediazione e stiamo cambiando la legge in modo che in futuro chiunque considerando l’azione giudiziaria sarà legalmente obbligato a partecipare ad una sessione informativa di mediazione e a valutare se questo possa essere un migliore approccio.
L’anno scorso, poco più di 17.000 persone hanno utilizzato con successo i fondi del gratuito patrocinio per risolvere questioni familiari e stiamo lavorando sodo con i fornitori di servizi di mediazione e di consulenza per garantire che più persone siano avvisate che esiste un’alternativa al processo”.
http://www.theguardian.com/law/2013/sep/30/mediation-services-legal-aid
Continua la campagna pro mediazione nonostante il cambio di Ministro della Giustizia
“When people separate we want them to do it in the least damaging way for everyone involved, especially children. That is why we want them to use the excellent mediation services available to agree a way forward, rather than have one forced upon them.”
Simon Hughes, Ministro della Giustizia inglese
7 gennaio 2014
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-25638627
La mediazione nel 1758 a Londra e a Philadelphia 100 anni dopo. E nel 2013?
La mediazione, nella quale un amico comune interpone i suoi buoni uffici, si rivela spesso efficace nel coinvolgere le parti contendenti nell’incontrarsi a metà strada, nel venire a una buona comprensione, nello stipulare un accordo o compromesso rispetto ai loro diritti, e, se la domanda si riferisce ad una offesa, nell’offrire e accettare una ragionevole soddisfazione.
L’ufficio del mediatore richiede un elevato grado di integrità, di prudenza e di capacità di eloquio.
Egli dovrebbe osservare una rigorosa imparzialità, dovrebbe ammorbidire i rimproveri dei contendenti, calmare i loro risentimenti, e disporre le loro menti ad una riconciliazione. Il suo dovere è quello di favorire pretese ben fondate, e di effettuarne il ripristino, in capo a ciascuna parte, per ciò che gli compete: ma lui non deve insistere in modo pignolo su una rigida giustizia. Lui è un conciliatore e non un giudice: la sua mansione è quella di procurare la pace, e di indurre chi ha la ragione dalla sua parte a cedere qualcuna delle sue pretese, se necessario, in vista di un così grande benedizione.
Emer de Vattel- Joseph Chitty, The law of nations; or, Principles of the law of nature: applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns, T.&J.W. Johnson & Co., 1858, p. 276.
India
Matematica
Secondo un prestigioso studio del 2013 in India c’erano 30.000.000 di casi pendenti che andrebbero ad esaurirsi secondo l’andamento corrente in 300 anni; in Italia nel 2010 c’erano 6.927.881 processi civili di merito pendenti.
Quanti anni ci vorranno per esaurirne il carico? secondo la matematica 60…
E se nel 2014 il Ministro della Giustizia nostrana fa riferimento a 9.000.000 di processi? Secondo la matematica 90…
Cfr. J. Martinez ed altri, DISPUTE SYSTEM DESIGN: A COMPARATIVE STUDY OF INDIA, ISRAEL AND CALIFORNIA in http://cardozojcr.com/wp-content/uploads/2013/05/CAC308.pdf)
Cfr. Senato della Repubblica XVII legislatura Dati statistici relativi all’amministrazione della giustizia in Italia in http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/063/Dossier_011.pdf)
Strumenti alternativi in India (e se ripensassimo il 185 bis c.p.c. ?)
L’arbitrato esiste in India dal 1899 (vi sono state anche due riforme: nel 1940 e nel 1996) mentre la mediazione informale è praticata da tempo immemorabile.
Dal 1987 (Legal Services Authorities Act 1987) la mediazione e il patrocinio legale gratuito per la medesima fanno parte integrante del sistema giurisdizionale indiano.
La mediazione è amministrata da Corti che si definiscono Lok Adalats.
La sezione 89 del Codice di Procedura Civile (in vigore dal 2002) prevede il seguente interessante tenore:
” 89 . Risoluzione delle controversie fuori dal tribunale – . ( 1) Qualora risulti al giudice che esistono elementi per un accordo che può essere accettabile per le parti, il giudice è tenuto a formulare le condizioni dell’accordo e a consegnarle alle parti per le loro osservazioni e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti, il giudice può riformulare i termini di un possibile accordo e sottoporre lo stesso a –
a) arbitrato ;
b) conciliazione ;
c) composizione giudiziaria, compresa la composizione attraverso Lok Adalat, oppure
d ) mediazione
( 2 ) Se una controversia è stata riferita –
( a) in arbitrato o in conciliazione, le disposizioni della legge sull’Arbitrato e sulla conciliazione del 1996 si applicano come se il procedimento di arbitrato o conciliazione fossero scelti per la composizione in base alle disposizioni di tale legge;
( b) alla Lok Adalat , il giudice rinvia la stessa controversia alla Lok Adalat secondo le disposizioni della sub sezione (1) della sezione 20 della Legal Services Authorities Act, 1987 e tutte le altre disposizioni di tale atto si applicano nei confronti della controversia in tale modo riferita alla Lok Adalat;
( c) per la composizione giudiziaria, il giudice rinvia la stessa a un istituto idoneo o persona e tale ente o la persona devono essere considerati una Lok Adalat e si applicano le disposizioni del Legal Services Autorità Act del 1987 come se la controversia sia stata sottoposti ad una Lok Adalat in base alle disposizioni di tale legge;
(d) per la mediazione, il giudice deve stendere un accordo di mediazione tra le parti ed esse devono seguirne le regole.
Irlanda
Da dove cominciare se si vuole andare in mediazione?
Un’utile guida si può trovare su http://www.icma.ie/where-to-start-2/
La traduco perché mi pare interessante.
Certo presuppone che si metta su un sistema completamente diverso dal nostro che è poi anche quello americano/inglese.
Bisogna allora interrogarsi su ciò che vogliamo e se il nostro modo di affrontare le controversie sia o meno (ancora) efficace
Teniamo conto che in Irlanda la mediazione è ormai come il prezzemolo, si trova in ogni settore pubblico e privato.
Nel passo peraltro si parla del primo incontro esplorativo, ma solo nel caso in cui ci sia incertezza sull’utilizzo dello strumento.
Come si noterà il loro modo di ragionare è profondamente differente dal nostro: il processo si prepara tra le parti durante il percorso di pace, in modo che sia chiaro a tutti alla fine quale opzione sia più opportuna da seguire.
Le parti sono dunque sempre in contatto e collaborano tra di loro, anche nella scelta del mediatore.
L’approccio poi sulle spese di mediazione appare rivoluzionario per il nostro paese, ma se ci pensiamo bene denota grande serietà di intenti che non può che ripagare.
Da dove cominciare?
– Esaminate la gamma di opzioni che possono aiutare a risolvere il problema. Definite i vostri obiettivi, i bisogni reali e le preoccupazioni e discutete le opzioni per raggiungerli. Se la mediazione sembra offrire un possibile progresso, ricordate a voi stessi i vantaggi della mediazione, tra cui la rapidità, il rapporto costo-efficacia, il controllo sul risultato, la riservatezza, la flessibilità, le soluzioni creative e l’esito.
– Avvicinate l’altra parte o il suo avvocato e informatevi sulla loro disponibilità a ricorrere alla mediazione. Se sono favorevoli si può fare riferimento al ‘Trova un Mediatore’ su questo sito e se sia possibile scegliere un mediatore da questo elenco. Visita la ‘ Selezione di un mediatore ‘ per alcuni suggerimenti utili.
-In alternativa , se un approccio diretto non può funzionare o non funziona , avvicinate uno dei mediatori della sezione ‘Trova un Mediatore ‘ su questo sito e chiedete loro di entrare in contatto con l’altra parte / avvocato per discutere l’idoneità del caso mediazione e la via da seguire: spesso può essere utile avere questo approccio iniziale effettuato da un pratico esperto neutrale di mediazione o da fornitore di servizi.
– Se l’avversario (o consulente legale ) è incerto , suggerite un incontro esplorativo, senza alcun impegno, con un mediatore, in cui si verifichi se per la materia la mediazione può essere utile e ci si informi sui costi, i tempi e la preparazione.
– Se incontrate in qualche fase riluttanza, chiedete all’avversario/avvocato quali siano le loro preoccupazioni (piuttosto che scambiarvi semplicemente le vostre posizioni giuridiche) e ascoltate la risposta.
– Considerare le alternative alla mediazione e le loro conseguenze in termini di costi, tempi, risultato e pubblicità.
– Ampliate il focus del processo di mediazione non limitandovi al solo raggiungimento di una soluzione, ma includendo lo scambio di informazioni, l’acquisizione della comprensione e del restringimento dei problemi.
– Create un piano d’azione con passaggi ben individuati per muovervi verso la mediazione: ricordate che non affrontate un processo uguale in tutti i casi – è un processo flessibile che può essere adattato alle esigenze della materia della controversia e richiede una buona preparazione ed eventuali follow-up.
– Cercate di lavorare in collaborazione con l’altra parte nella preparazione dei documenti per la mediazione; redigete una ” lista della spesa ” delle informazioni di cui abbisognate dall’altra parte in modo che la mediazione si tramuti in uno strumento significativo; considerate quali informazioni e/o documenti che si possono rivelare all’altra parte la possa aiutare a comprendere meglio la propria posizione e a progredire verso una soluzione, esaminate l’ipotesi di elaborare un programma congiunto di informazione/punti controversi.
– Suggerite che sia l’altra parte/avvocato a scegliere il mediatore e approvate la sua scelta.
– Offritevi di pagare le spese di mediazione, e magari anche le spese di rappresentanza legale che affronterebbe l’altra parte.
– Le forti emozioni espresse dagli attori della mediazione in questa fase sono utili e possono essere utilizzate nel processo di mediazione.
Riservatezza
In Irlanda gli Organismi non si pongono il problema di creare case history, considerano (grazie a Dio) la riservatezza ancora un valore e allora per pubblicizzare la loro attività chiedono a coloro che vanno in mediazione di dare dei giudizi sull’esperienza che hanno vissuto.
Ad esempio:
“We had a particularly difficult situation with a senior employee that looked impossible to solve without recourse to the courts, a process that would have caused a huge financial strain on the company, not to mention the internal rifts such disputes can bring. The impasse was affecting our company’s ability to operate and luckily for us Brian was recommended as a mediator. Neither side of the dispute had any previous dealings with Brian but both came to a resolution in little over 24 hours after his direct involvement. The resolution was acceptable to both parties and represented a sea-change from where parties had stood just a day before. The binding agreement was reached with diplomacy, tact and absolute professionalism.”
http://www.mediatetoday.info/content/testimonials
Italia
Abuso del diritto
“Nella procedura sommaria dipenderà di regola dall’arbitrio delle parti valersi o no dell’opera di avvocati. Tuttavia ordinandolo il giudice espressamente, ciascuna di esse sarà tenuta a comparire in giudizio di persona. E’ pure rimesso al prudente arbitrio del giudice, a seconda delle circostanze del caso, di sentire le parti sopra cose di fatto in assenza dei loro avvocati; come anche di rimuovere dal foro quelle parti che importunassero con riprodurre temerariamente petizioni e domande già respinte, o che si contenessero in modo inconveniente o non avessero al capacità di esporre le loro occorrenze in modo intellegibile, e potrà rimetterle a farsi rappresentare da un avvocato”. (§ 10 Ordinanza del Ministero della Giustizia 32 marzo 1850)
Nel processo austriaco dell’Ottocento esisteva il giudizio sommario e quello ordinario.
Il rito sommario veniva utilizzato per le controversie che per valore ammontavano a meno di 600 lire austriache e per le questione locatizie e di affittanza.
Il § 10 riportato riguarda appunto il rito sommario.
Appare interessante perché ci fa intendere due cose:1) Le persone avevano un gran voglia di litigare anche nel XIX secolo e in ogni dove visto che questa norma valeva per il Lombardo-Veneto ma anche per l’Austria. 2) I loro avvocati potevano alimentare il litigio ovvero agire da calmiere di pretese insensate.
Per arginare questo desiderio di conflitto il § 14 stabiliva che se le parti non avessero fatto un tentativo di conciliazione preventivo fosse il giudice quello obbligato a tentare la conciliazione.
E dunque l’uomo sembra non aver mutato granché la sua natura.
È forse questo il vero nemico della moderna mediazione? La voglia di litigare che connatura l’uomo?
Caduceo o giustizia?
Qualche giorno fa sono sceso alla fermata S. Giorgio della Metro, quella davanti al famoso palazzo genovese. Ci sarò passato davanti centinaia di volte eppure non avevo mai notato che su ben due facciate laterali sono riprodotte l’effige di Mercurio col suo caduceo e quella della dea Fortuna con la cornucopia.
Mi è parsa una associazione significativa e mi sono chiesto che messaggio voleva dare l’artista; perché associare il dio della medicina alla dea della fortuna. Forse che la nostra vita oscilla tra la fede nella scienza e la realtà del caso?
Poi ho pensato che Mercurio era anche il dio della mercanzia, degli affari ed allora l’associazione con la dea fortuna in un porto di mare, mi è parsa particolarmente azzeccata.
Ma Mercurio era anche il dio dei viaggi. E dunque un velo di tristezza è calato: il pittore avverte i naviganti che i viaggi sono legati alla fortuna.
O forse il dipinto ha ancora un’altra finalità.
Mercurio era considerato il dio della pace e della conciliazione degli opposti.
Ovidio lo definisce pacifer.
I due serpenti nel caduceo alludono proprio al mito della pace: si dice che Mercurio avesse incontrato due serpenti che lottavano tra loro e li avesse dissuasi dalla lotta.
Galileo Galilei si riferì al caduceo con queste parole:”Componi gli animi avversi e spegni queste fiamme”.
Presso gli antichi erano gli araldi che portavano il caduceo e che erano detti appunto caduceatores.
Il caduceo era sì il simbolo del commercio, ma appunto anche della pace e della conciliazione di cui appunto gli ambasciatori erano latori.
Gli araldi facevano peraltro anche i cancellieri nei processi: ancora oggi i cancellieri spagnoli conciliano al pari dei giudici.
Nel processo antico si prevaleva sull’avversario in base ai voti riportati; la sentenza era dunque frutto della fortuna, ossia della benevolenza che si stimolava nei giurati pagando i logografi giudiziari che erano in grado di suscitare empatia.
E dunque il viaggiatore, commerciante che approdava a Genova un tempo poteva scegliere tra la conciliazione e la fortuna… E nel 2013?
Filippo Cervo, un avvocato di pace
Nel 1862 un avvocato che si chiamava Filippo Cervo si accinse a scrivere un progetto di legge che venne pubblicato nel 1872.
Se questo progetto fosse stato adottato probabilmente sarebbe cambiata la nostra società.
In alcuni paesi d’Europa tuttavia (ad esempio in Belgio) la lezione di Cervo è stata presa in considerazione nel 2013.
L’art. 180 di questo progetto così recitava:
In ogni pubblico giudizio finita la pubblica discussione, pria di emanar a rigor di giustizia la sua pronunziazione, anche senza nessuna istanza, tenti zelantemente la conciliazione.
In questo caso, solo allor, che la conciliazione riesca, invece di qualunque giudiziaria pronunziazione, distendane relativo verbale di conciliazione.
E l’art. 182 prevedeva:
Il verbale di conciliazione, qualunque sia il valore delle controversie conciliate, abbia forza di giudicato; contenga espressa la dichiarazione di questa forza; sia munito dell’ordine e comando di esecuzione; e sia eseguito come ogni altro giudicato.
Sia lode a tutti gli uomini illuminati di buona volontà!
http://books.google.it/books?id=o1jiVWiGTGYC&pg=PA83&dq=conciliazione+avvocato&hl=it&sa=X&ei=KymmUtOnE8aM7Aaao4CACQ&ved=0CD8Q6AEwAzgK#v=onepage&q=conciliazione%20avvocato&f=false
Conciliatori romani
Dalle tavole dei Pontefici risulta che Tarquinio regnò trent’anni e che il suo regno finì con un assassinio. All’epoca i re erano anche giudici e soprattutto conciliatori verso chiunque si fosse rivolto alla loro autorità. Così i suoi assassini finsero di voler fare una conciliazione e lo ferirono a morte.
Storia romana di M. B. G. Niebuhr, Volume 2, Tipografia Tizzoni, 1833, p. 48.
…Era Fenea di parere che si dovesse valersi di Antioco piuttosto come conciliatore di pace, come mediatore nelle cose controverse coi Romani, che come condottiero di guerra. La di lui venuta e maestà avrebbero avuto maggiore forza che le sue armi, a generare nei Romani un non so quale rispetto. Gli uomini, piuttosto che guerreggiare, cedono volentieri tante cose, che non potrebbero indursi a cedere con la forza e con le armi.
TITO LIVIO, Capito XLV della Storia Romana.
Così si andava in giudizio in Lombardia sino al 1848
Le differenze marcate rispetto alla mediazione odierna investono il regime della prescrizione e il fatto che in conciliazione non si poteva chiamare lo Stato.
CAPITOLO II.
Esperimento di conciliazione.
925. In generale non può introdursi in giudizio una causa con formale petizione, se prima non siasi tentalo l’esperimento di conciliazione. A tal uopo la parte che intende accampare qualche pretesa, deve fare istanza a voce od in iscritto presso la Giudicatura affinchè venga citato l’avversario al dello esperimento (§ I della Notif. gov., 2 marzo 1824, sull’esperimento di conciliazione.)
926. Ciascuna delle parti dovrà comparire in persona, e solamente in caso d’impedimento, potrà farsi rappresentare da un procuratore munito di legale mandalo contenente anche la facoltà di transigere. Nel comparire, poi, dovrà ciascuna parte portar seco gli identici documenti dei quali crederà potersi prevalere a sostegno delle sue ragioni (§ 5, Notif. cit.).
927. Le convenzioni che per avventura si stipulassero in seguilo alle esortazioni del giudice hanno forza ed effetto di convenzioni giudiziali (3). S’intende però da sé che simili convenzioni, ove siano state conchiuse da un tutore, curatore od amministratore di beni dello Stato o comunitativi, per essere valide od operative, dovranno riportare l’approvazione del rispettivo giudice pupillare o della competente superiore autorità in tutti quei casi in cui la legge lo richiede.
928. Desiderando alcuna delle parti, in qualunque tempo di avere copia legalizzala o semplice dell’avvenuta convenzione, potrà chiederla ed ottenerla dalla Giudicatura, osservandosi quanto è prescritto pel rilascio d’altre copie {§ 8, Notif. cit.).
929. Qualora al giudice non riesca di conciliare le parti comparse, ovvero se il citato non comparisse entro tutta l’ora destinala nella citazione, ed il citante giustifica la seguita intimazione del libello, il giudice rilascia al citante un certificato di non seguita conciliazione per renitenza delle parti, o per non essere comparso il citalo.
La parte contumace incorre sempre nella multa di italiane lire 10. Quando la conciliazione non riesce, le dichiarazioni fatte dalle parti nell’esperimento non potranno recar pregiudizio a veruna di esse, né si potrà farle valere nella via ordinaria civile nemmeno come una confessione stragiudiziale (§ 9).
930. Senza certificato di non seguila conciliazione non si potrà dar corso ad una petizione né verbale né in iscritto, perciò se ne dovrà sempre far menzione nella petizione, ed esso dovrà essere allegato nel duplo della petizione in iscritto od essere annesso in originale al rotolo degli atti (§ 10).
931. La citazione in conciliazione, non essendo una formale petizione, non interrompe il corso della prescrizione. Ognuno, cui interessa, avrà quindi cura di far seguire tale citazione in tempo, onde poter accampare la sua azione con formale petizione, per l’effetto d’interrompere il corso della prescrizione medesima. Qualora poi il termine della prescrizione fosse prossimo a scadere, colui che accampar vuole un’azione, potrà, nell’atto di far seguire la citazione per la conciliazione, presentare contemporaneamente anche la relativa formale petizione; ma questa non verrà evasa fino a che non sia seguito l’esperimento di conciliazione (§ 12).
932. Dall’obbligo del precedente esperimento di conciliazione sono eccettuali i seguenti casi:
a) ove il vigente Regolamento del processo civile fissa un termine per la presentazione della petizione, per esempio, per la riconvenzione, per la petizione relativa al cauzionale arresto personale o sequestro;
b) ove si tratta di un urgente provvisionale provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili;
b) quando l’una o l’altra delle parli non è domiciliata nel distretto della Giudicatura, presso la quale deve incamminarsi la causa (§ 13).
933. Sono poi escluse affatto come non qualificate per la previa conciliazione le seguenti istanze:
a) quelle che riferiscono un oggetto che non è d’immediata ed esclusiva , competenza giudiziaria;
b) le petizioni ed istanze sopra punti incidenti in causa già incamminata;
e) le petizioni relative ad un processo edittale;
d) la resa di conto da presentarsi per la giudiziale liquidazione:
e) le petizioni per separazione di letto e mensa, per le quali sussista un’apposita istruzione intorno al modo di procedere (§ 14);
f) quelle relative ad affari di commercio e cambio;
g) quelle in cui il R. Demanio (Fisco) è parte in causa (§ 18);
h) le petizioni esecutive che si fondono sopra documento pieno-provante;
i) o sopra atti notarili.
Così tanto per precisare in tema di mancato compenso dei mediatori
Nel 1855 nel Regno d’Italia sabaudo non era la conciliazione ad essere gratuita, ma poteva esserlo l’arbitrato.
Per ogni conciliazione scritta sotto le 100 lire si dovevano 50 centesimi, mentre se ne pagavano 30 se la conciliazione non andava a buon fine.
Per ogni conciliazione sopra le 100 lire si pagava 1 lira oltre ai diritti di scritturazione per ogni pagina in più alla prima (40 centesimi). Di talché le conciliazioni o si facevano verbali o comunque il verbale era assai succinto anche quando si trattava di affari importanti.
E di ciò dovrebbero tenere conto tutti i giudici che invece oggi vorrebbero verbali corposi per addebitare le spese ex art. 91 c.p.c.: tale pretesa oltre che contraria all’istituto della mediazione, sarebbe contraria anche alla tradizione in materia di conciliazione.
Dicevamo che era l’arbitrato poteva essere gratuito.
Il criterio era il seguente: “o gli arbitri sono persone che per studio e professione fanno speciale ufficio di comporre le liti, e vennero eletti dalle parti riguardando specialmente la loro capacità legale, ed in questo caso gli onorari sono dovuti perché i compromittenti riferendosi ad arbitri cui ufficio è comporre i litigi, è da presumersi che avessero intenzione di corrispondere gli onorari; o gli arbitri vennero eletti piuttosto avuto riguardo alla relazione d’amicizia che corre colla persona dei compromittenti, ed in questo caso la presunzione sta che gli onorari non siano dovuti, poiché è assurdo il supporre che un amico o un conoscente si sia interposto tra i due litiganti onde comporre le liti col loro desiderio di guadagno” (Manuale pratico di procedura civile pel regno d’Italia, 1861, E. DALMAZZO editore, p. 860).
E dunque si vede che il nostro legislatore considera i mediatori come amici o conoscenti delle parti, e non come soggetti il cui officio è quello di aiutare a comporre le liti, mentre presume che gli arbitri siano sempre dei professionisti legali e che dunque vadano pagati: chiunque vede pertanto che almeno in base alla nostra risalente tradizione siamo completamente fuori strada.
Dove andranno a comprare i consumatori stranieri?
La Comunità è assai preoccupata per la circolazione di beni e servizi.
Nel 2011 la perdita di PIL dovuta a problemi legati all’acquisto di beni e servizi in Europa è stata dello 0,3%.
Stiamo parlano di 56 miliardi di dollari. Ossia quasi del prodotto interno lordo della Slovenia.
Nel 2012 i consumi privati (-1,3%) e gli investimenti (-4,1%) sono peraltro ulteriormente peggiorati .
Nel 2009 il 29% dei cittadini europei ha acquistato beni in un diverso paese membro.
Nel 2010 il 37% dei cittadini europei ha acquistato beni tramite internet.
Gli acquisti on-line sono stati nel 2011 il 7,2% del PIL del Regno Unito: ossia 164 miliardi di dollari .
Ma nel 2009 solo l’8% ha rischiato a comprare on line in un altro paese membro, per l’incertezza che deriva dal non sapere che cosa fare e a chi rivolgersi.
Il 71% dei consumatori ritiene che la risoluzione delle controversie sia più difficile se si effettuano acquisti all’estero.
Non è un caso che la direttiva ADR ultima così stabilisca: “È deplorevole che, nonostante le raccomandazioni della Commissione 98/257/CE, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, l’ADR non sia stato attuato correttamente e non funzioni in modo soddisfacente in tutte le zone geografiche o in tutti i settori economici dell’Unione” (Considerando n. 6 della DIRETTIVA 2013/11/UE)
La raccomandazione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001 è stata perlatro richiamata anche dal considerando 18 della direttiva 52/08: ”Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che rientri nell’ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti”.
In conformità alle raccomandazioni citate è stato creato un database di organi che si occupano di ADR.
In Europa Il 41% dei 750 sistemi di ADR di questo database non è conosciuto né dagli utenti né dalle autorità .
Oltre 500 sistemi di ADR sono stati notificati alla Comunità Europea.
E quindi se il 59% degli organismi è sconosciuto lavorano 292 sistemi su 750.
Tra i 25 stati che hanno notificato organi di ADR alla Commissione l’Italia è oggi al 15° posto insieme a Paesi Bassi e Finlandia
L’Italia ha notificato all’Europa 4 organismi sui 129 presenti: le CC.I.AA. di Roma e Milano, i collegi arbitrali di Telecom Italia e l’Ombudsman dell’ABI.
Meno organi notificati di noi li hanno Estonia, Svezia, Lituania, Lettonia, Slovenia, Romania Cipro, Slovacchia.
Prima di noi ci sono Germania, Spagna, Grecia, Polonia, Bulgaria, Belgio, Repubblica Ceca, Austria, Francia, Danimarca, Ungheria, Regno Unito, Portogallo, Malta, Irlanda.
La classifica in dettaglio è la seguente:
Germania (203 organismi su 229).
Spagna 73
Grecia 60
Polonia 54
Bulgaria 25
Belgio 23
Repubblica Ceca 20
Austria 20
Francia 20
Danimarca 19
Ungheria 18
Regno Unito 17
Portogallo 14
Malta 6
Irlanda 5
Italia 4
Paesi Bassi 4
Finlandia 4
Estonia 2
Svezia 1
Lituania 1
Lettonia 1
Slovenia 1
Romania 1
Cipro 1
Slovacchia 0
La corsa all’arbitrato
Ho appena ricevuto una brochure per un corso di arbitrato ove trovo scritto quanto segue: “Laureati in tutte le discipline e/o iscritti a un Ordine o a un Collegio professionale”.
Ma come? Avete fatto tanto rumore per i mediatori che avevano il solo compito di spegnere il conflitto ed ora per i giudici privati che emettono decisioni richiedete i medesimi requisiti?
Non sarà che il mercato del pesce ha aperto i battenti? Solo che il pesce è andato a male e puzza terribilmente… Il tanfo mi disgusta…
Lo sciatore ed il mediatore
Lo sciatore non differisce granché dal mediatore.
Lo sciatore ha come compito, infatti, quello di governare due sci che sono portati ad andare ognuno per proprio conto e di solito a divergere.
Se proprio vogliamo trovare una differenza essa riguarda forse la partenza.
Lo sciatore, almeno quello coscienzioso e previdente, inizia a scaldarsi i muscoli su piste facili o perlomeno non troppo ripide.
Il mediatore invece non ha la possibilità di svolgere un riscaldamento graduale: egli è costretto ad iniziare a freddo e sempre dalla pista nera, spesso nelle peggiori circostanze di tempo e di stato della neve.
Per il resto seguono, direi, le medesime regole.
Non si possono costringere gli sci ad andare in una certa direzione. Lo sciatore che ci provasse cadrebbe immancabilmente dopo aver incrociato le code; il mediatore che provasse a forzare le persone ad accordarsi, “incrocerebbe solo le code”; in altre parole incollerebbe un bicchiere rotto col nastro adesivo da pacchi: provate a berci dentro!
Il mediatore e lo sciatore hanno di solito l’accortezza di non prendere eccessiva velocità: ogni sciatore quando non è particolarmente stanco si augura che la pista non finisca mai.
E il mediatore che finisca perlomeno al momento opportuno.
Lo sciatore che scende per la pista di regola non si guarda indietro, perché cadrebbe a faccia in avanti.
Anche il mediatore non si guarda indietro, perché il passato delle persone potrebbe innescare pericolosi recriminazioni che gli farebbero perdere il suo ruolo.
Le ginocchia dello sciatore poi sono sempre inclinate verso le punte, mai vanno tenute indietro a meno che la neve fresca non lo impedisca.
Solo così gli sci gireranno dolcemente e senza particolare sforzo dello sciatore, semplicemente con un impercettibile, ma costante spostamento del peso del corpo.
Anche il mediatore è sempre proteso verso il futuro (il presente dura pochissimo) e si sposta tra le parti costantemente senza perdere la sua imparzialità.
Quando chiudono la curva gli sci scivolano verso l’esterno e lo sciatore li asseconda senza opporre resistenza. L’esterno o “verso monte” è una meta che si ripete invariabilmente: gli sci dimenticano la loro natura e pattinano dolcemente all’unisono con un delicato sibilo.
Il “verso monte” potrebbe corrispondere in mediazione agli interessi: gli sciatori non si dispongono di primo acchito in quella direzione, la pulsione naturale è quella di proseguire diritti e allora arrivano velocemente cunette insormontabili, lastre di ghiaccio impossibili da superare, stradine strette e ripidissime che si affacciano sui burroni; mantenere il punto accorcerebbe davvero pericolosamente il percorso.
Il “verso monte” è quel denominatore comune che ti permette di stare in piedi e di esplorare ogni direzione ampliando il raggio di curva, sì anche del 37% (inimmaginabile un tempo: ci si fermava al 27% o giù di lì).
Le punte non si debbono incrociare però, pena la perdita di equilibrio; ognuno deve mantenere la propria individualità anche se a pochi centimetri di distanza. Nessuna prevaricazione se si vuole arrivare in fondo. E così il mediatore che segue le parti in parallelo cercando di non sposare le rivendicazioni di una persona piuttosto che di un’altra.
Ma la cosa che avvicina di più il mediatore allo sciatore è lo stile: nessuno dei due ha semplicemente come finalità quella di arrivare in fondo, ma di arrivarci disegnando la pista con armonia, con quella armonia che in primo luogo sono gli sci, le persone, a percepire.
Jonas Daniel Meyer
fu uno dei giuristi più illuminati del XVIII e del XIX secolo ed un’autorità indiscussa nella conoscenza delle legislazioni straniere.
Fu uno dei paladini dell’avvocatura di cui divenne parte a soli sedici anni: i suoi insegnamenti erano ben vivi e citati ancora in epoca fascista, nonostante egli fosse Ebreo.
In oggi certe posizioni dell’avvocatura sono ancora riconducibili a lui e alla lotta secolare che combatté con i suoi scritti per opporsi a quelli di Voltaire in materia di conciliazione.
Ecco cosa scriveva in merito all’Ordine degli avvocati.
“Anche sotto un altro aspetto la costituzione d’un ordine d’avvocati è sommamente utile alla società. Ai magistrati in carica viene inutilmente affidata la cura di conciliare le parti; certi funzionarii estranei alla cognizion della causa non possono fare sperare un gran successo; non si bada troppo alle loro rimostranze, e la loro intercessione altro non è che una mera formalità: i giudici stessi non ponno, in sul bel principio d’ una procedura, intavolar misure di conciliazione in una causa che assolutamente ei non conoscene, e vanno a rischio di perdere la loro imparzialità, se qualche tentativo serio andasse mai a vuoto: sul finire della procedura l’esperimento è inutile, e il giudice può solo difficilmente celare la sua opinione, la quale conosciuta che sia, fa svanire qualunque speranza di conciliazione. I soli avvocati possono prevenire le contestazioni incipienti, sopir certe liti in sul punto dello scoppiare, terminare gli affari già pendenti, calmare e mitigare gli animi, e far rinascere la concordia e l’ armonia turbato dalle controversie: una buona tendenza della curia conduce a un novello beneficio”.
http://books.google.it/books?pg=PA457&dq=conciliazione+avvocato&ei=OjemUqjdAo2y7AbT74HQAQ&id=mfxTAAAAcAAJ&hl=it#v=onepage&q=conciliazione%20avvocato&f=false
Negoziazione obbligatoria
Hanno strumenti di negoziazione obbligatoria tra gli altri i seguenti stati del Mondo che costituiscono più di un quarto degli stati totali: Giappone, Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Germania, Italia, Stati Uniti, Romania, Israele, Irlanda, Argentina, Colombia, Australia, Giappone, Taiwan, Repubblica delle Filippine, Nuova Zelanda, Canada, Dubai, Nigeria, Botswana, Ghana, Capo Verde, Egitto, Gambia, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritius, Lesoto, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zimbawe, Cina, Francia, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Svezia, Estonia, Norvegia, Grecia, Slovenia, Repubblica Ceca, Finlandia,Cipro, Svizzera, Islanda, Slovenia, Spagna, Liechtenstein, Repubblica di Corea.
Quesito
Ma se è vero che l’avvocato non ha interesse a stare in giudizio sette anni mezzo perché non viene pagato per la durata del processo (così ha dichiarato il presidente del Consiglio dell’Ordine di Napoli ad Unomattina un paio di giorni fa), perché non venire in mediazione e risolvere la questione in poche ore?
Quesiti
1) Quesiti per Arlene McCarty
Che cosa intende per alternativa alle cause civili, rapida, efficiente ed economica?
È sufficiente che le persone si siedano dieci minuti intorno ad un tavolo per realizzare l’idea di alternativa europea al processo?
I mediatori sono professionisti?
I professionisti sono a loro volta consumatori?
Se sì come fanno ad acquistare beni e servizi?
Se si devono proteggere i consumatori perché non si mettono a carico dei professionisti con cui essi interagiscono i costi della composizione degli eventuali conflitti?
Non sarebbe un modo efficace di responsabilizzarli circa una più corretta esecuzione delle prestazioni?
Se mi si intasa la canna fumaria e chiamo uno spazzacamino e lo spazzacamino non riesce a liberare il condotto, pagherò la persona che mi è venuta ad aiutare o gli dirò che siccome era una prova nulla gli è dovuto?
Cara Arlene McCarty, ha mai partecipato ad una mediazione in Italia dopo il decreto del fare?
2) Quesiti per il Ministero della Giustizia
Quali progressi vede per l’Italia signor Ministro?
L’Italia è secondo lei un ordinamento evoluto?
In che modo gli operatori del settore devono favorire l’emergere di un nuovo approccio culturale?
Quale revisione della mediazione ha operato il governo per ottemperare al dettato della Corte Costituzionale?
Il regime speciale riservato dal legislatore all’avvocato-mediatore e più in generale al mediatore implica che lo stesso debba lavorare gratis?
Caro Ministro, ha mai partecipato ad una mediazione?
Sciopero?
Noi mediatori non possiamo più accettare di essere definiti come un balzello per i cittadini.
Proprio oggi che lavoriamo gratis è un’ignominia inaccettabile! Che fare?
Se non facciamo nulla diamo ragione ai calunniatori…
E incrociare finalmente le braccia?
Malesia
Poteri del mediatore in Malesia
In Malesia è il mediatore che decide se un soggetto che non è parte possa partecipare alla mediazione.
Il che significa che gli avvocati ed i consulenti od altri terzi possono partecipare alla seduta soltanto se il mediatore ha acconsentito.
Le parti invece possono decidere se ammettere o meno in mediazione alcuno dell’ufficio del mediatore.
Così prevede il combinato disposto degli articoli 3 e 9 del Mediation act 2012 (Law of Malaysia 749).
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20120622_749_BI_Act%20749%20BI.pdf
Michigan
Mediazione delegata
Mentre da noi è aperto il dibattito sulle conseguenze di una mancata presentazione delle parti alla sessione ordinata dal giudice (sentenza di improcedibilità, continuazione del processo come se niente fosse ecc…) a Detroit il Presidente di una Corte Distrettuale ha imposto a due parti e ai loro avvocati di un giudizio fallimentare, di partecipare ad una mediazione l’antivigilia e la vigilia di Natale.
Nell’Ordine si specifica che i partecipanti alla mediazione dovranno poter disporre dei diritti in contesa e che una mancata comparizione comporterà oltre a sanzioni pecuniarie una pronuncia di default judgment, ossia una sentenza di condanna contumaciale.
Noi non sappiamo come sia andata a finire ma… è di sicuro un modo per promuovere lo strumento alternativo.
http://www.wxyz.com/dpp/news/region/detroit/chief-judge-orders-christmas-eve-mediation-session-in-detroit-bankruptcy
Nuova Zelanda
Gratuito patrocinio in mediazione in Nuova Zelanda
In Nuova Zelanda si può ottenere il gratuito patrocinio in mediazione a due condizioni: 1) che la controversia sia adatta alla mediazione 2) che ci siano ragionevoli possibilità che la controversia sia risolta con questa procedura.
art. 27 Legal Services Act 2011
http://www.legislation.govt.nz
Il mediatore familiare in Nuova Zelanda nel 2013
7 Qualification and competency requirements
The following qualification and competency requirements must be applied in deciding whether a person meets the criteria in section 9(1) of the Act:
(a)the person must,—
(i)in the case of an appointment by the Secretary, be a member of or affiliated to an approved dispute resolution organisation; and
(ii)in the case of an appointment by an approved dispute resolution organisation, be a member of or affiliated to that organisation:
(b)the person must have enough experience of resolving disputes using mediation to provide reasonable assurance of competence in providing dispute resolution services in the context of Family Court processes:
(c)the person must be able to determine and facilitate appropriate processes to help parties to mediation reach agreements that best promote the welfare of children:
(d)the person must be able to help people to participate effectively in mediation:
(e)the person must be able to help participants in mediation to develop skills and strategies for managing future disagreements:
(f)the person must have knowledge and understanding of Family Court processes and family law, particularly—
(i)the Care of Children Act 2004 and the effect of sections 4, 5, and 6 of that Act; and
(ii)the Act:
(g)the person must be able to apply and communicate laws, rules, and purposes of the family justice system:
(h)the person must have adequate knowledge and understanding of child development and its relevance to day-to-day care and contact issues:
(i)the person must be culturally aware, in particular of Māori values and concepts:
(j)the person must be able to address diversity in parties to mediation:
(k)the person must be able to—
(i)assess parties to mediation, and their circumstances and history, for factors (in particular, in relation to possible domestic violence) indicating risks that may arise during, or in the context of, mediation sessions; and
(ii)manage any risks likely to arise.
Family Dispute Resolution Regulations 2013
Qatar
In Qatar la mediazione è facoltativa (obbligatoria quella delegata). Il mediatore non ha una particolare formazione (chi si prepara lo fa per cinque giorni) e quello stranierò guadagna tra i 1000 ed i 20.000 € a mediazione che vengono tassati al 5% (il mediatore interno invece viene tassato al 10%). Si media in inglese ed in arabo.
http://www.lalive.ch/data/publications/ME2013_Qatar.pdf
Russia
“Credo che la mediazione non provocherà una diminuzione del ruolo dei tribunali od una perdita della loro autorità; al contrario liberati dal fardello delle cause i tribunali saranno in grado di aumentare la loro efficienza e l’effetto si tradurrà in un maggiore qualità nella risoluzione dei casi”.
Amore Yevgenyevna Koropenko, Vice Presidente della Corte Regionale di Tambov e Presidente del Consiglio Giudiziario, 2013
http://mediators.ru/rus/regional_mediation/tambov/news/text4
Spagna
Arriverà la mediazione obbligatoria in Spagna?
Il 4 dicembre 2013 i magistrati di GEMME (l’associazione europea dei giudici per la mediazione) hanno chiesto al Ministro della Giustizia spagnola di cambiare il modello di mediazione processuale e di introdurre la sessione informativa di mediazione obbligatoria.
http://www.lawyerpress.com/news/2013_12/0412_13_001.html
Mediazione ed assicurazione in Spagna
L’università di Barcellona e DAS assicurazioni (un colosso mondiale) hanno presentato il 5 novembre 2013 uno studio sul rapporto tra mediazione e settore assicurativo. Nel corso della relazione è stato dimostrato che la mediazione nel settore assicurativo è un meccanismo che promuove il dialogo e permette la risoluzione dei conflitti in modo più agile, efficiente e conveniente, riducendo per un alta percentuale il conflitto.
Il ricorso alla mediazione come alternativa al contenzioso può portare un risparmio di tempo e denaro, e, soprattutto , garantire un elevato livello di soddisfazione per i cittadini.
http://www.lawyerpress.com/news/2013_11/0511_13_004.html
Un comune intento…
Mentre da noi ognuno corre per conto suo… verso il baratro… in Spagna e precisamente a Madrid, La Camera di Commercio, i Consigli dell’ordine degli avvocati, dei notai e dei procuratori hanno firmato un protocollo di attuazione per dare impulso alla mediazione.
http://www.lawyerpress.com/news/2013_10/3010_13_001.html
Singapore
La mediazione a Singapore nel 2014
Più persone a Singapore si rivolgono alla mediazione per risolvere le dispute in luogo del giudizio, perché fa risparmiare tempo e pesanti spese legali, e dà loro voce sull’esito.
In otto anni le mediazioni sono quadruplicate presso il Centro di Mediazione di Singapore (SMC) che si occupa di questioni molto rilevanti (200 casi che possono superare il 200 milioni di dollari).
Tre casi su quattro vengono risolti dal Centro in mediazione.
Sono gli stessi avvocati a consigliare la mediazione ai loro clienti, specie quando si tratti di controversie mediche.
Mentre un processo può costare 100.000 $ per parte, la mediazione non arriva a 10.000 $.
Amolat Singh, un avvocato mediatore di Singapore, ha precisato che “E’ opinione convenzionale che il processo sia ancora la salvezza dell’avvocato, ma ora la marea sta cambiando. La verità è che le parti spesso non riescono a pagare spese legali commisurate all’impegno ed al tempo. E’ meglio chiudere la controversia ed andare avanti”.
Il governo stesso sta pensando a mettere su un centro di mediazione commerciale internazionale.
http://news.asiaone.com/news/singapore/more-choosing-mediation-over-court?page=0%2C1
Stati Uniti
L’avvocato della pace
Tra il 1894 ed il 1920 a Washington venne pubblicata una rivista che si intitolava The advocate of peace.
E dunque mi fa piacere sapere che in quel periodo esisteva almeno un avvocato della pace, così come ora esistono gli avvocati mediatori di diritto.
Ma a parte la facile battuta, questa rivista ci racconta che prima del 1905 i rapporti tra le potenze belligeranti erano regolati da una Convenzione dell’Aia che mi pare utile riportare perché cita regole che si affermarono nei rapporti internazionali ai tempi dell’Atene classica:
I. Le Potenze firmatarie concordano di utilizzare al meglio gli sforzi per assicurare la soluzione pacifica delle differenze internazionali.
II . Le Potenze firmatarie concordano di ricorrere per quanto le circostanze consentano, ai buoni uffici o alla mediazione di uno o più amichevoli
poteri.
III . Uno o più poteri, estranei alla controversia, dovrebbero, di propria iniziativa, e per quanto le circostanze lo permetteranno, prestare i loro buoni uffici o la mediazione agli Stati in conflitto. Il diritto di offrire i buoni uffici o la mediazione appartiene ai poteri che sono estranei alla controversia, anche durante il corso delle ostilità. L’esercizio di questo diritto non sarà mai considerato da una o dall’altra delle parti in contestazione come un atto ostile.
Cfr. https://archive.org/details/jstor-25751867
Trasparenza americana
Mentre noi in Italia parliamo di milioni di cause, vedi la recente esternazione del Guardasigilli, ma sembra che le responsabilità vadano ricercate nell’Iperuranio, dal 1990 col Civil Justice Reform Act (CJRA) si impone al Direttore dell’Ufficio Amministrativo dei Tribunali degli Stati Uniti (OA) di fare un rapporto semestrale sulle cause pendenti (l’obbligo sussiste anche oggi nel 2014): i rapporti peraltro sono molto interessanti perché per ogni giudice vengono indicati i casi pendenti.
Allego qui il link di quello del 2013.
http://www.uscourts.gov/uscourts/statistics/cjra/2013-03/CJRAMarch2013.pdf
Da questa indagine peraltro nel 1990 è partita propriamente l’esperienza degli avvocati americani nella mediazione, perché in un primo tempo si privilegiava l’arbitrato, ma visti i risultati in campo deflativo si consentì che si aprisse genericamente a tutte le forme di ADR, compresa quindi la mediazione. Noi invece facciamo il cammino contrario: si vede che la storia e l’esperienza americana non ci ha insegnato alcunché.
Compenso del mediatore aderente alla AAA
Qualora le parti abbiano richiesto la mediazione della American Arbitration Association valgono le seguenti regole per il compenso del mediatore.
Ricordo che la AAA insieme all’ABA (American Bar Association) è l’organizzazione che ha redatto gli standard della mediazione che sono osservati dai neutri statunitensi.
La AAA ha uffici in tutto il Paese.
Ebbene quando si contatta la AAA non si paga una indennità di avvio della mediazione.
Il compenso è orario e può andare dai 125 agli 800 dollari (dipende dal mediatore che si sceglie).
La mediazione dura come minimo quattro ore e dunque il compenso può oscillare nel minimo tra i 500 ed i 3200 dollari.
Se per qualche motivo non si tiene l’incontro al mediatore spettano comunque 250 dollari più spese eventualmente effettuate e le tasse.
E’ il mediatore che copre col suo guadagno le spese sostenute dalla AAA.
http://www.adr.org/aaa/faces/services/disputeresolutionservices/mediation?_afrWindowId=dvcj2vnvn_458&_afrLoop=1032880300387488&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=15pkhaprug_145#%40%3F_afrWindowId%3Ddvcj2vnvn_458%26_afrLoop%3D1032880300387488%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Ddvcj2vnvn_486
Texas
Un bel suggerimento
In Texas c’è uno studio legale tra i tanti che ha avuto una brillante idea. Peccato che da noi non si possa mettere in pratica visto che si deve passare obbligatoriamente attraverso gli organismi.
Ebbene in questo studio la mediazione può essere di mezza giornata (inizia alle 9 e finisce di solito alle 13) o di una giornata intera.
La cosa che trovo interessante è che durante la procedura full time si consuma un pranzo di lavoro (può essere un pranzo o un rinfresco).
La mediazione può tenersi anche nei fine settimana con la maggiorazione di 250 dollari, e pure nelle ore serali con un costo aggiuntivo.
Se ci sono più persone che sono rappresentate da uno stesso avvocato sono considerati una parte sola ai fini del pagamento.
Se le parti sono solo due la sessione di mezza giornata costa 495 $ per parte; quella di una giornata intera 850 $ per parte.
Se le parti sono tre il prezzo scende.
Il compenso è dovuto comunque se la sessione non è disdettata almeno cinque giorni prima, ameno che la stessa non sia riprenotata.
http://www.mccollorprimaveralawfirm.com/mediation.htm
YEMEN
La mediazione in Yemen
In Yemen, come del resto in Kenya o alle Isole Salomone, la giustizia tradizionale è spesso percepita come familiare, trasparente e partecipativa.
Il suo obiettivo è la riconciliazione piuttosto che la punizione.
Difficilmente si adiscono i giudici statali perché sono sovraccarichi di lavoro: nel 2005 il tempo di un processo era di 8-10 anni.
La cosa curiosa è che in Yemen le leggi sono consuetudinarie, ma le mediazioni vengono registrate per iscritto.
Il processo di mediazione pone in campo valori tribali che privilegiano gli obblighi di responsabilità reciproca.
La mediazione, la cooperazione, l’autonomia e la flessibilità sono valori che definiscono l’identità tribale in Yemen.
Non ci sono limiti di materia: in Yemen ogni conflitto è cosa privata e pubblica allo stesso tempo.
Il mediatore di solito è un capo tribù od un uomo con buona reputazione.
Per iniziare la mediazione le parti consegnano il loro pugnale, la pistola o il fucile o i loro orologi (nel caso di controversie minori) al mediatore.
Le donne che invece di solito non sono armate consegnano denaro, gioielli ed orologi.
Ciò corrisponde per loro alla nostra domanda di mediazione: alla fine della procedura questi oggetti verranno restituiti.
Il processo è informale e si svolge in una grande camera.
Può partecipare chi lo desidera.
Gli uomini masticano uno stimolante, fumano pipe ad acqua o sigarette o sorseggiano bevande calde.
Chiunque può intervenire e dare liberamente la sua opinione.
Mentre gli uomini discutono, le donne si radunano altrove sullo stesso caso ed i bambini fungono da messaggeri tra un gruppo e l’altro spiegando a ciascun gruppo a che punto è arrivata la discussione.
In serata il caso viene discusso in ogni famiglia.
Il giorno seguente gli uomini portano in mediazione le opinioni delle loro mogli, madri e sorelle.
Il mediatore è in realtà un arbitro che decide però sulla base dei precedenti verbali di mediazione; il verbale di altra mediazione funge cioè da precedente legale.
Il verbale della mediazione di solito contiene una richiesta di riparazione per un contendente o per tutti e due (quando si riconosce che entrambi hanno torto).
I dettagli di tutte le controversie che sono formalmente mediate sono appunto registrate per iscritto e conservate dai leader locali o dall’arbitro.
L’intervento del terzo è considerato normale e auspicabile in Yemen a tutti i livelli del conflitto e ha un notevole valore preventivo. Se non ci sono testimoni del litigio i disputanti gridano a gran voce e con rabbia l’uno contro l’altro per attirare l’attenzione di un mediatore.
Najwa Adra, TRIBAL MEDIATION IN YEMEN AND ITS IMPLICATIONS TO DEVELOPMENT in http://www.najwaadra.net/tribalmediation.pdf
44.415423
8.916741